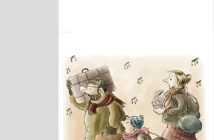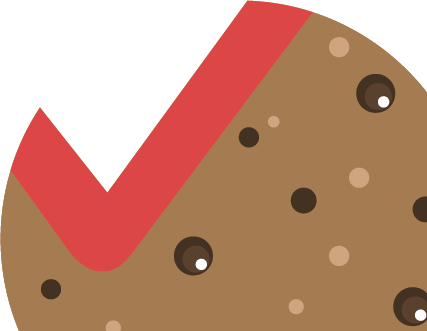Mariarosa Bricchi, nel suo libro edito da il Saggiatore, sostiene che “La lingua è un’orchestra” perché “l’italiano non è uno, ma tanti”. Quali sono i tanti italiani cui fa riferimento.
Sì, credo che sia corretto pensare all’italiano come a una lingua plurale, mobile, variopinta: dunque a un repertorio ricchissimo di scelte possibili. Le varietà hanno a che fare prima di tutto con la storia, perché la lingua cambia nel tempo, e noi possediamo una illustre tradizione letteraria, la cui vicenda secolare è lì a ricordarci che l’italiano che parliamo oggi è il risultato di lunghe evoluzioni e piccole rivoluzioni. Le varietà hanno a che fare con la geografia: adesso come in passato i dialetti e le specificità locali sono importanti, e vivacemente rappresentati. E poi hanno a che fare con la situazione sociale e culturale, e con la specializzazione professionale di chi usa la lingua; e con il canale di trasmissione (scritto e parlato, ma anche il parlato a distanza, come quello della radio e della televisione, e la scrittura dei social media). Ma ancora non basta: accanto alle varietà dei linguaggi disponibili, ci sono le infinite realizzazioni stilistiche degli scrittori. In una nota dello Zibaldone, Leopardi scriveva: “La lingua italiana è piuttosto un complesso di lingue che una lingua sola, potendo tanto variare secondo soggetti e stili e caratteri degli scrittori”.
Scrive nella sua introduzione: l’italiano o lo domini o ti domina. Che intende?
Un grande linguista del Settecento, Melchiorre Cesarotti, ha detto che gli scrittori di genio “fanno indocilire la loro lingua”. L’italiano, come qualunque lingua, è uno strumento opulento e complicato. Ed è uno strumento di potere. Capire con precisione i discorsi degli altri, e saper utilizzare le parole per esprimere con chiarezza ed efficacia il proprio pensiero sono requisiti indispensabili non solo agli “scrittori di genio”, ma per la vita associata di tutti noi. Mentre l’impotenza di fronte a quello che non si capisce fino in fondo o non si riesce a dire è un fenomeno, triste, di esclusione. Dominare la lingua vuol dire conoscerla, saperla controllare, ricavarne piacere e conoscenze: usarla non per sopravvivere, ma per vivere.
L’eccesso di congiuntivo e le parole della burocrazia vengono identificati come i grandi malanni dell’italiano. Ma non si dice da più parti che il congiuntivo sta scomparendo?
In realtà quella della morte del congiuntivo è un po’ una favola che riaffiora di quando in quando, insieme ad altre lamentazioni sull’italiano (anche la morte del punto e virgola è un tema ricorrente). Sappiamo invece da diversi studi che il congiuntivo non sta sparendo, ma è impiegato con ragionevole frequenza e discreta correttezza sia nella lingua scritta sia in quella parlata. Affiora, piuttosto, un problema inverso: ho provato a dimostrare che un sintomo diffuso di uso incerto dell’italiano è non l’assenza, ma l’eccesso di congiuntivi, anche in situazioni dove la grammatica prescrive l’uso dell’indicativo. Un fenomeno che va probabilmente ricondotto all’insicurezza di chi non domina agevolmente la lingua, e all’idea ricevuta che il congiuntivo è comunque l’opzione più colta, dunque quella meno rischiosa. Resta il fatto che il congiuntivo è un tema caldo, e che saperlo usare correttamente è un po’ diventato, nella percezione comune, un altro modo di dire che si sa usare correttamente la lingua in generale.
La nostra lingua è anche quella filtrata dalle parole dei traduttori, visto che molti dei libri che leggiamo sono traduzioni. Per questo il volume è dedicato a coloro che lei definisce in maniera puntuale e affettuosa “collezionisti di varietà linguistiche”?
Il confronto con l’italiano è solo l’ultima in ordine di tempo tra le sfide che un traduttore affronta. Ma è anche una sfida decisiva, perché in quel faccia a faccia con un codice radicalmente altro dall’originale, in quel momento in cui la questione diventa restituire la personalità del testo di partenza in un nuovo universo linguistico si gioca tanto della riuscita di una traduzione. Per questo è essenziale, per i traduttori, muoversi con agio nelle regole, nelle varietà, nei registri dell’italiano. I traduttori sono, insomma, un gruppo di scriventi iper-specializzati, esigenti e consapevoli. La lingua è il loro strumento, e alla lingua il loro lavoro ritorna, arricchendola – quando i risultati sono di qualità – di altri colori e di nuovo slancio.
Noi siamo un’associazione di media italofoni. Cosa pensa dell’italiano degli altri, cioè di chi vive in Paesi dove l’italiano è lingua ufficiale o di minoranza o di chi sceglie l’italiano come lingua adottiva, come direbbe Amin Maalouf?
Uno degli esempi più belli che conosco di italiano degli altri è quello delle lettere di Mozart. Che l’italiano lo sapeva, perché era la lingua delle corti di Vienna e Salisburgo, e del mondo musicale del Settecento. Lo sapeva, e si divertiva a mescolarlo col tedesco e col francese, in una girandola di giochi linguistici acrobatici e arlecchineschi (per esempio: “schreibe mir, und seye nicht so faul, altrimenti avrete qualche bastonate di me. quel plaisir!”). Ecco, adottare una lingua o usarla conoscendone anche altre mi sembra, prima di tutto, una forma di contatto, di dialogo: l’italiano non è più solo, ma sta vicino a codici diversi, dialoga, si contamina. Un po’ come succede con le traduzioni. E, naturalmente, in questo dialogo sta molta della vitalità, e del futuro, dell’italiano.
Mariarosa Bricchi, storica della lingua italiana e editor, si occupa di prosa letteraria dell’Ottocento e del Novecento, e di lingua delle traduzioni. Tra i suoi libri: La roca trombazza. Lessico arcaico e letterario nella prosa narrativa dell’Ottocento italiano (Edizioni dell’Orso, 2000); Manganelli e la menzogna. Notizie su «Hilarotragoedia» (Interlinea, 2002); Grammatica del buio. Strategie testuali di Manzoni saggista (Centro Nazionale Studi Manzoniani, 2017). Ha curato Il buonuomo Lenin di Curzio Malaparte (Adelphi, 2018).