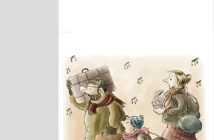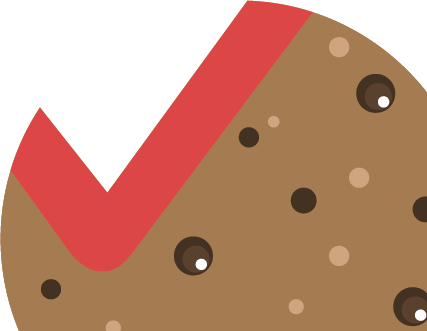Cos’è la lingua, e cos’è il dialetto? cosa esprimiamo con l’una e cosa esprimiamo con l’altro? La lingua batte dove il dente duole. Un dialogo tra Andrea Camilleri e Tullio De Mauro che raccontano come la lingua esprima chi siamo veramente. E una profonda, giusta, verità: in Italia abbiamo tante lingue.
Cos’è la lingua, e cos’è il dialetto? cosa esprimiamo con l’una e cosa esprimiamo con l’altro? La lingua batte dove il dente duole. Un dialogo tra Andrea Camilleri e Tullio De Mauro che raccontano come la lingua esprima chi siamo veramente. E una profonda, giusta, verità: in Italia abbiamo tante lingue.
Andrea Camilleri
Il dialetto è sempre la lingua degli affetti, un fatto confidenziale, intimo, familiare. Come diceva Pirandello, la parola del dialetto è la cosa stessa, perché il dialetto di una cosa esprime il sentimento, mentre la lingua di quella stessa cosa esprime il concetto. A me con il dialetto, con la lingua del cuore, che non è soltanto del cuore ma qualcosa di ancora più complesso, succede una cosa appassionante. Lo dico da persona che scrive. Mi capita di usare parole dialettali che esprimono compiutamente, rotondamente, come un sasso, quello che io volevo dire, e non trovo l’equivalente nella lingua italiana. Non è solo una questione di cuore, è anche di testa. Testa e cuore.
Tullio De Mauro
Il dialetto non è solo la lingua delle emozioni. L’ho capito in Sicilia, da non siciliano, quando sono arrivato lì, professore all’università, accolto dalle famiglie dei colleghi. Si partiva con l’italiano, nel senso che tutti parlavano in italiano. Ma appena la discussione si accendeva – e quando c’era Sciascia capitava spesso – e magari si passava alla politica, improvvisamente cambiavano registro linguistico. Un po’ alla volta slittavano nel dialetto, e dell’italiano si scordavano. Gli uomini, per parlare di argomenti più impegnativi intellettualmente, usavano il dialetto. Perché a Venezia come a Palermo, quando il discorso si fa serio, si usa il dialetto.
Ve ne proponiamo un brano tratto dal sito dell’editore Laterza:
Scrivila come l’hai raccontata a me
Tutto può cambiare, ma non la lingua che ci portiamo dentro, anzi che ci contiene dentro di sé come un mondo più esclusivo e definitivo del ventre materno.
Italo Calvino
Camilleri Io all’inizio scrivevo poesie. Avevo cominciato da giovane, anzi da bambino. Allora le poesie si scrivevano alla mamma, si scrivevano al duce, ai Templi di Agrigento. I modelli erano Carducci e D’Annunzio. Più D’Annunzio che Carducci: lui era, come diceva Pirandello, uno scrittore di parole, ci sguazzava dentro.
Solo quando diventavi più adulto, scoprivi che esistevano altri poeti. Mi ricordo una professoressa – si chiamava Giudice –, che mi disse: «Guarda che oltre Pascoli ci sono altri poeti, ci sono per esempio i crepuscolari, Gozzano, Corazzini, se vuoi te li presto io, e ti presto anche un poeta che si chiama Montale». Quella per me fu la rivoluzione del ’48 perché, dopo di allora, il mio modo di scrivere poesie cambiò completamente. La poesia per me è come una sorta di shuttle; pigliamo per esempio un sonetto, hai a disposizione 14 versi di 11 sillabe ognuno, una miseria, perciò se non hai una propulsione ascensionale immediata, non decolli. La lettura del Canzoniere di Petrarca fu fondamentale per capire, per scoprire, la perfezione di un meccanismo metrico vero con le sue regole non ovviabili. Oggi, invece, in qualsiasi canzone senti rimare due infiniti o due sostantivi come se niente fosse. Ebbi la fortuna di avere pubblicate le mie prime poesie da gente qualificata. Ungaretti le incluse in una sua antologia, lo stesso fece Fasolo, e vinsi dei concorsi di poesia importanti. Dopo aver pubblicato poche altre poesie smisi perché dirottato sul teatro. E questo accadeva verso gli anni Cinquanta. Scrissi dei racconti e questi riuscivo a scriverli in italiano, erano elzeviri, racconti brevi, che occupavano una colonna e mezzo di giornale. Oltre non riuscivo ad andare. Il passaggio c’è stato nel momento in cui ho deciso che mi ero stufato di raccontare in teatro storie d’altri, con parole d’altri. E per raccontare la storia mia, dovevo trovare un mio modo di scrivere. Un mio modo di scrivere che rispettasse sempre e comunque la struttura dell’italiano.
De Mauro Più di altri libri oggi circolanti, i tuoi mi paiono capaci di distillare l’essenza più segreta e peculiare della lingua, le sue grandi capacità di «escursione», di passaggio da un registro all’altro perfino entro una stessa frase…
Camilleri Voglio dirti perché cominciai subito a scrivere nella lingua in cui scrivo. Sentivo che il mio italiano aveva un respiro corto. Come dicevo, giovanissimo, scrivevo poesie e racconti brevi… in italiano. E andava bene anche per i racconti di terza pagina. Il problema si presentava con i racconti lunghi. Se ne interrompevo la scrittura, metti conto per andare a dormire, l’indomani mattina, quando riprendevo, avevo difficoltà a ritrovare lo stesso tono, lo stesso timbro del giorno avanti. Era come scrivere una lettera iniziandola in francese e continuandola in inglese. Allora mi sono detto: «Così non riuscirò mai a scrivere». Colsi l’ottimo pretesto e mi dedicai interamente al teatro; abilmente plagiato dal mio maestro Orazio Costa, divenni incapace di scrivere anche un solo rigo, un solo verso. Mi capitò, però, una cosa divertente con Quasimodo, che voleva pubblicare le mie poesie in un’antologia di poeti siciliani. «Maestro – gli dissi –, sono già state tutte pubblicate le poesie che per me ne valevano la pena. Di nuove non ne ho altre». Quasimodo insistette dicendomi di fare una selezione delle migliori già pubblicate. E di nuovo mi rifiutai, sentendole da me lontanissime. E allora lui mi disse che ci pensassi ancora, avrebbe aspettato l’ultimo momento prima di andare in stampa e mi avrebbe fatto telefonare da una sua collaboratrice, la poetessa Agata Italia Cecchini. Una mattina, alle otto, mi telefona un signore: «Dottor Camilleri?». «Sì, sono io». «Sono il marito di Italia». Noi da anni avevamo una cameriera che si chiamava Italia ed era zitella incallita. Caddi dalle nuvole: «Oh madonna! – dico – Perché Italia è sposata? Io la sapevo nubile». «Veramente siamo sposati da cinque anni». «Ma com’è che io non ne so niente?». E lui, piccato: «Ma scusi, lei perché lo dovrebbe sapere?». «Lo devo sapere perché la vedo ogni giorno». «Lei vede ogni giorno mia moglie?». Insomma, a farla breve, lui era il marito di Agata Italia Cecchini, la collaboratrice di Quasimodo, che aveva chiesto al marito il favore di chiamarmi per la risposta sulla pubblicazione delle mie poesie! E perciò io pensavo alla mia Italia, e lui alla sua!
De Mauro Di teatro ne hai fatto tanto…
Camilleri Sì, molto. Sul palco, in radio e in televisione. Tra le tante produzioni, ho seguito passo passo tutta l’opera teatrale del Ruzzante per il terzo programma Rai, protagonista Marcello Moretti. Ruzzante mi stravolse. La vera scoperta dell’importanza del dialetto non avvenne attraverso il mio siciliano, ma con Ruzzante e Goldoni. Poi cominciai a leggere Belli e ci sprofondai letteralmente, mi si aprì un mondo. In seguito, mi sforzai molto di leggere Carlo Porta. Avevo cominciato ad esplorare qualcosa che a scuola non veniva manco nominata, e fu in qualche modo la mia rivincita sull’italiano. Scoprii un nuovo universo espressivo e mi tornò la voglia di scrivere.
De Mauro E poi?
Camilleri Decisivo fu mio padre. Era ricoverato al Gemelli di Roma e stava morendo. Con lui avevo avuto rapporti difficili, complessi, ma sapere che gli restava poco tempo cambiò le cose. Non lo abbandonai un momento, per un mese e mezzo abbandonai il lavoro, lasciai perdere tutto per stare con lui. Parlavamo molto. Un giorno, per distrarlo, gli dissi: «Lo sai papà, ho pensato a una storia», e gli raccontai la storia del mio primo romanzo Il corso delle cose. Era un racconto che da tempo avevo in testa ma fu lì, in quella stanza di ospedale, che prese forma concreta. E mio padre: «Perché non la scrivi?». «Eh papà, perché in italiano mi viene difficile scrivere». «E perché la devi scrivere in italiano? Scrivila come l’hai raccontata a me». Cominciai a riflettere sulle sue parole. Non ritenevo praticabile seguire la strada del dialetto totale, così come era stato con mio padre, perché io volevo farmi capire anche dagli altri. Allora cominciai ad analizzare come parlavamo noi in famiglia. E da quella prima riflessione ho fatto tantissimi tentativi per trovare l’equilibrio nel mio modo di raccontare. Equilibrio che poteva essere rotto dalla scelta delle parole in lingua, perché dovevano essere parole con la stessa valenza, la stessa massa della parola del dialetto. È stato un lungo esercizio, lo si può vedere attraverso i miei libri, è un lavoro che non si arresta mai, neanche oggi. È tanto vero che all’atto della pubblicazione di un libro che per esempio ho scritto quattro anni fa, sono obbligato a riscriverlo quasi di sana pianta, non la fabula, ma la scrittura, perché è in evoluzione continua. Io ho scritto anche dei libri in italiano, voglio dire completamente in lingua italiana. E continuo a scriverli. Mi sono guadagnato l’italiano, una conquista tardiva ma per me importante. Del resto, anche nei romanzi scritti in vigatese parto sempre da una struttura molto solida in lingua italiana. Il lavoro dialettale è successivo, ma non si tratta di incastonare parole in dialetto all’interno di frasi strutturalmente italiane, quanto piuttosto di seguire il flusso di un suono, componendo una sorta di partitura che invece delle note adopera il suono delle parole. Per arrivare ad un impasto unico, dove non si riconosce più il lavoro strutturale che c’è dietro. Il risultato deve avere la consistenza della farina lievitata e pronta a diventare pane. È per questo che butto tutte le successive stesure del testo lasciando salva solo la definitiva. Appena il libro è edito, butto via tutto, non lascio traccia dei miei delitti. Ho una sorta di repulsione, di rigetto. Quando i traduttori, dopo tre o quattro anni dall’uscita del libro, mi chiedono che cosa ho voluto dire nella frase a pagina 128, mi viene un malessere e un nervosismo che chi mi è vicino conosce. Cerco di rimuovere qualsiasi indizio che mi ricordi il mio delitto. Non riesco a rileggermi. E se ne sono costretto, nella maggior parte dei casi, provo un’acuta insoddisfazione per come ho scritto.
De Mauro Ma succede anche nella ricerca storica, scientifica. Croce diceva che non rileggeva volentieri i suoi libri vecchi, che gli parevano cadaveri. Einstein dice di più, dice che è nel momento in cui proviamo disgusto per la scienza e gli studi cui stiamo dedicando la vita – e succede –, è in quel momento che nascono le grandi svolte e le idee ed esperienze nuove. L’insoddisfazione per quello che si sta scrivendo e pensando è un sale prezioso…
Camilleri Di solito, nella scrittura sono molto veloce, quando ho un tema che voglio scrivere, questo mi continua a lavorare nel cervello mentre faccio altro, mentre parlo, mentre cammino, mentre mangio. Sono come dissociato. Qualunque cosa faccia, continuo sempre a pensare a quello che voglio scrivere. Così quando mi seggo al computer, è come se lavorassi sotto dettatura. Stampo poi quello che ho scritto e lo rileggo ad alta voce, ricomponendolo magari tre o quattro volte. Con Il re di Girgenti è stato diverso. Ci sono voluti cinque anni per scriverlo (non ho mai impiegato più di un anno per un romanzo). Le difficoltà non erano solo di natura linguistica, di scrittura, perché fin dall’inizio mi ero prefisso un compito: di partire dal comico e arrivare a una sorta di tragico-favolistico, volevo vedere se avevo capacità di tenuta, se avevo la mano per fare questo passaggio. Già questo mi fece capire che avevo bisogno di più tempo. Poi c’era la questione del dialetto. Essendo ambientato nel Seicento, per poter iniziare a scrivere, mi rifeci al siciliano di Giovanni Meli, e passai molto tempo a leggerlo fino a quando riuscii ad appropriarmi delle parole e dei suoni che mi interessavano. Sennonché questo romanzo è ambientato assai prima della nascita dell’abate Meli, e quindi divenne per me necessario reinventarmi il linguaggio arcaizzandolo. Partivo dunque da un linguaggio letterario che avrei dovuto comunque liberare, ripulire da ogni alone letterario. È questa operazione che mi ha portato via tanto tempo. Poi ci ho lavorato molto, a modo mio, senza prendere appunti – non ci riesco proprio se devo scrivere una cosa che mi piace, li prendo solo per le cose noiose. Ho impiegato tempo a cercare le parole, le cose, a intessere un gioco continuo e abbastanza evidente di richiami letterari, da Manzoni a D’Annunzio, e inoltre mi ero posto un punto di partenza e un punto d’arrivo. Partivo dal Cantico di san Juan de la Cruz, che sta nella prima parte del Re di Girgenti e che ho trasformato in un fatto erotico, e arrivavo ad una meta lontana, al som de l’escalina di Dante quando nel XXVI canto del Purgatorio fa parlare Arnaut Daniel. La scrittura è una scrittura che da contadina, terragna, passa via via a un registro che usa parole sempre più magiche, «mammalucchigne» diciamo in siciliano, fino ad arrivare a parole più leggere, favolistiche. Questo è stato l’esercizio di scrittura che ho fatto, però oggi non avrei più la forza di riprovarci.
De Mauro Ricordo che Consolo polemizzava continuamente con te sui modi in cui usare il dialetto…
Camilleri Io non rispondevo mai. Il suo è un dialetto da abate Meli, un dialetto molto letterario. Basta leggere Lo Spasimo di Palermo. Il mio non lo è per niente. Di questo mi accusava, di portare il dialetto a un livello estremamente basso. Mentre lui adoperava un dialetto che non usava neanche Pirandello, che si guardava bene dal dialetto letterario. Pirandello usa un dialettaccio girgentano meraviglioso.
De Mauro A proposito di Pirandello, lui diceva che ci sono scrittori di parole e scrittori di cose. D’Annunzio, per esempio, per lui era uno scrittore di parole e Verga uno scrittore di cose.
Camilleri Io mi ritengo uno scrittore di cose, più le parole assomigliano alle cose, più si rafforzano le cose. Una grossa scoperta è stata, per me, la traduzione siciliana del Ciclope di Euripide fatta da Pirandello. Lui fece una traduzione in dialetto siciliano per la Grande Compagnia del Mediterraneo, verso il 1920, ed è un lavoro straordinario. In questa traduzione adopera tre diverse parlate siciliane provocando un incredibile divertimento. Il Ciclope parla come un grosso massaro, ricco proprietario di mandrie, che adopera un linguaggio contadino greve con certe parole che francamente il borghese siciliano non capisce. Per esempio la parola gramusceddru. Il gramusceddru è il vitellino appena nato, che non si regge in piedi, che barcolla, quello è il gramusceddru. E lui rivolgendosi a Ulisse dice: «Senti una cosa, gramusceddru», perché è gigantesco e davanti a lui Ulisse è un esserino neonato; c’è questo gusto proprio di una certa grevezza, pesantezza. Invece Ulisse parla proprio un siciliano che vuole avvicinarsi alla lingua italiana, ed era il linguaggio dei pupari siciliani che credevano di parlare in italiano e invece parlavano una commistione fantasiosa, per me meravigliosa. E lui, Ulisse, siccome ha fatto il militare, come Totò, a Cuneo, insomma ha conosciuto il mondo, parla questo suo «taliano» un po’ alla Catarella… Io mi sono ispirato proprio a questa traduzione per il mio Catarella. E invece il capo dei contadini, Sileno, è mafioso e quindi usa mezze parole… lascia intendere, lascia supporre: «Non lo saccio, non lo viddi, non c’ero, ero distante». Bellissimo. Allora questo divertimento ho cercato di portarlo dentro la mia scrittura. Trovo che nelle parole, nella costruzione di una frase dialettale, ci sia un ritmo interno che per me non aveva l’equivalente nell’italiano. Il mio problema era di ritrovare quindi lo stesso ritmo del dialetto nella lingua italiana. Ci sono momenti felici in cui ho il possesso totale di questo mio modo di scrivere, ma altre volte è veramente faticoso, mentalmente faticoso, perché devo stare attento, come un bravo chimico devo ricordarmi la formula e dosare opportunamente la mia lingua, e non cerco mai la composizione più facile, ma quella per me più autentica, per evitare di banalizzare tutto.
Andrea Camilleri, Tullio De Mauro
Andrea Camilleri (Porto Empedocle, 1925), scrittore, regista di teatro, televisione e radio, sceneggiatore, ha insegnato regia presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica. Con Sellerio ha pubblicato quasi tutti i suoi romanzi, da La strage dimenticata del 1984 a La rivoluzione della luna del 2013, oltre a quelli con protagonista il commissario Salvo Montalbano, tutti grandi successi letterari, tradotti in più di trenta lingue.
Tullio De Mauro (Torre Annunziata, NA, 1932) ha insegnato Filosofia del linguaggio e Linguistica generale nell'Università Sapienza di Roma, dove ora è emerito. Per UTET ha pubblicato Grande dizionario italiano dell’uso (8 voll., 2007).