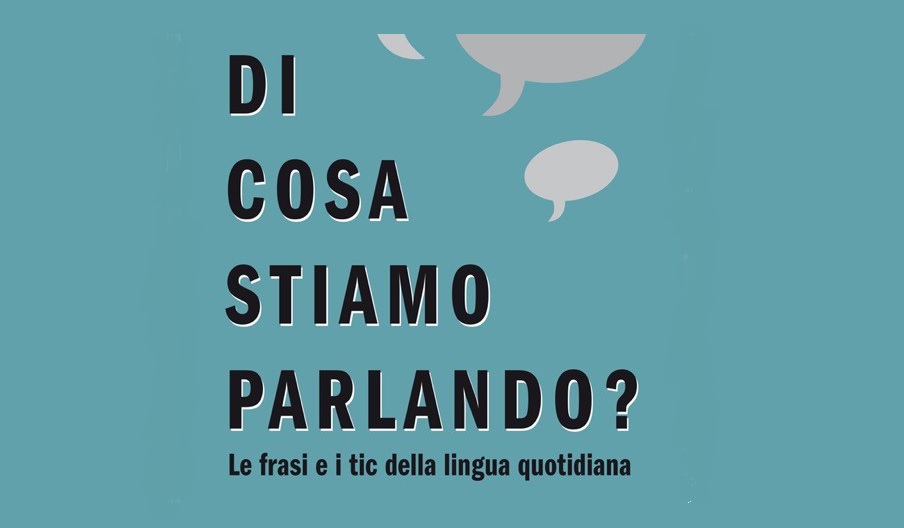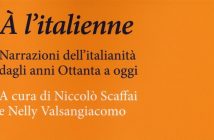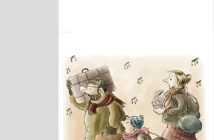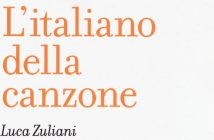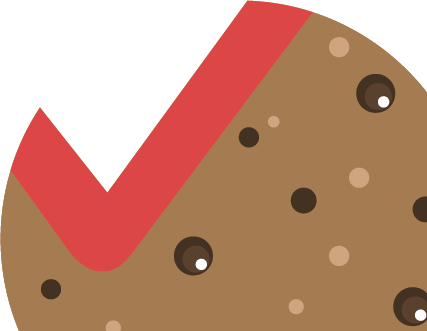Dieci autori commentano tic, stereotipi, modi di dire entrati nella lingua italiana nel volume “Di cosa stiamo parlando”, Enrico Damiani editore, con un’introduzione di Filippo La Porta.
Dieci autori commentano tic, stereotipi, modi di dire entrati nella lingua italiana nel volume “Di cosa stiamo parlando”, Enrico Damiani editore, con un’introduzione di Filippo La Porta.
Filippo la Porta di cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando delle frasi fatte, dei cliché e dei tic della lingua che tutti adoperiamo ogni giorno nella conversazione. L’intenzione del libro non è di condannarli, di stigmatizzarli, ma di assumerli come specchio fedele della società italiana, anche nelle sue trasformazioni. Il nostro è un manifesto contro il conformismo (contro la lingua “conforme”, sciatta) ma anche contro lo snobismo. Non ci sentiamo superiori nel commentare questi tic, e ovviamente molti di essi li usiamo anche noi. In particolare io uso quello per me più odioso, “Come dire?”, quasi uno status symbol, il tic del ceto riflessivo, degli “intelligenti”. Però ci aiutano a capire la mentalità, il costume di un paese, e di un’epoca.
C’è il modo di dire mutuato dal linguaggio manageriale, da quello politico, da quello calcistico, da quello televisivo.
Sì, certo, ognuno di questi ambiti ha il suo gergo. Mi pare che il giornalismo sportivo, e anzi calcistico, abbia un ruolo propositivo molto spiccato: “un attimino” cominciò a farlo circolare il calciatore Bettega negli anni’80, e poi quel tale “fa la differenza” e tante altre espressioni…Ma anche la pubblicità: “Allora ditelo”…
Testi di alcuni autori, come Dorfles, Della Valle, Ciabatti, Scaraffia, rappresentano un’Italia, anzi un popolo italiano, vittima di un presente gramo e con poche speranze nel futuro: bellissimi, grandissima, H24 come a far vedere che siamo sempre impegnati, occupati, ma non si sa a far cosa fino alle parole stampella di chi non ha nulla da dire. E’ un panorama un po’ triste.
Appunto: parole o espressioni “stampella”: va bene usarle, ci fanno prendere tempo, sono frasi formulari che garantiscono la funzione “fatica” del linguaggio (cioè: per mantenere il contatto), ma poi dobbiamo appendere a queste “stampelle” un pensiero nostro, un’immagine nostra.
La lingua viva è in continuo mutamento, ricca di contaminazioni e impurità, nonché di inevitabili stereotipi che sono spie preziose di cambiamento. Come evitare di cadere nello snobismo e nella degenerazione dei grammarnazi?
Non siamo i custodi sussiegosi della lingua, i puristi inflessibili della Crusca, né mi spaventano gli anglicismi, pure invadenti (alcuni poi sono necessari, straordinariamente sintetici: ad es. “briefing”,). Però mi sembra interessante studiare, analizzare i tic perché ci mostrano in modo trasparente l’ethos, la “filosofia” dell’Italia contemporanea.
Nella sua introduzione definisce questi tic “spie preziose della trasformazione del costume e della mentalità. Sono tracce, indizi e documenti veridici dell’inconscio della comunità”. Quali tracce e quali indizi allora sulla lingua e sulla comunità italiana?
Velocemente: i tic della rassicurazione ad oltranza (“Non c’è problema”, Tuttaposto?”), quelli improbabili e compensatori (“Assolutamente”, detto in un paese dove tutto è provvisorio, approssimativo, ipotetico), quelli dell’alibi permanente (“Ci può stare”, “In qualche modo”), quelli che simulano precisione e tecnologi (“Esatto” al posto di “sì”), quelli affettati (“Buona giornata”), quelli che rimandano al narcisismo (“è un problema tuo”, “non me ne può fregare di meno”), e via di seguito, anzi “e quant’altro”. Ma concludo con la parafrasi di due detti celebri: “essere o non essere: non c’è problema”, e poi Cesare, passato il Rubicone: “Tipo che il dado è tratto”.
GLI AUTORI
Teresa Ciabatti, Giuseppe Culicchia, Valeria Della Valle, Piero Dorfles, Vincenzo Ostuni, Antonio Pascale, Giuseppe Scaraffia, Simonetta Sciandivasci, Nadia Terranova, Edoardo Zuccato.
Filippo La Porta
Critico e scrittore, collabora a quotidiani e riviste, tra cui il “Domenicale” del “Sole24ore”e “Il Messaggero”. Tra i suoi libri ricordiamo “La nuova narrativa italiana”, Bollati Boringhieri 1995, “Maestri irregolari”, Bollati Boringhieri 2007, “Meno letteratura, per favore”, Bollati Boringhieri, 2010, “Pasolini”, Il Mulino, 2012, “Poesia come esperienza. Una formazione nei versi”, Fazi 2013, “Roma è una bugia”, Laterza 2014, “Indaffarati”, Bompiani 2016, “Prendere tempo: conversazione con Marc Augé”, Castelvecchi 2016, “Di cosa siamo parlando?” (cura e prefazione), Enrico Damiani Editore 2017. In uscita nel 2018: “Il bene e gli altri. Dante e un’etica per il primo millennio”, Bompiani, “Manifesto del Partito Comunista”, Marx-Engels, saggio introduttivo, Giunti. Ha realizzato per Rai-cinema un documentario su Berlino, tiene corsi di scrittura in varie università.