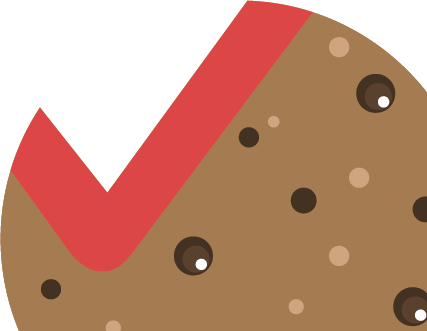(20/03/2015) La scrittrice Simonetta Tassinari su IlLibraio.it si interroga sul presente e il futuro dell’italiano, una lingua a rischio. Vi proponiamo l’articolo in versione integrale pubblicato sul sito illibraio.it.
(20/03/2015) La scrittrice Simonetta Tassinari su IlLibraio.it si interroga sul presente e il futuro dell’italiano, una lingua a rischio. Vi proponiamo l’articolo in versione integrale pubblicato sul sito illibraio.it.
di Simonetta Tassinari*
Le parole volano, spariscono, talvolta riemergono, magari con un altro significato, da sempre; se così non fosse, diremmo ancora “eziandio” e “imperrocchè”. Tuttavia, processo aperto non significa senza regole né limiti. Ogni nuova parola inglese che introduciamo inutilmente corrisponde a una parola italiana che se ne va, si rinchiude nello stanzino delle scope, ci si addormenta e, quando si va ad aprirle la porta, si scopre che è svanita. “Va bene” è stato pressoché cancellato da “Ok” e “Mi dà una risposta?” con “Posso avere un feedback?”, eppure un altro pericolo, un nemico interno, si annida anche in quell’ italiano ripetitivo e uniformato nel quale, per imitazione, si diffondono agenti patogeni lessicali che si trasmettono di bocca in bocca. Che fine hanno fatto gli infiniti sinonimi, gli usi calzanti e precisi della nostra lingua, dotata di un’inesauribile ricchezza che ci permette di esprimere lo stesso significato mentale attraverso diversissime forme?
Chi è stato l’untore? Chi ha cominciato, chi la smetterà? L’economia è una fervida ispiratrice: “risorsa”, “valore aggiunto” , “inflazionato”, “sdoganato” s’insinuano ovunque. “Importante” non significa più solo “rilevante” o “notevole”, ma sostituisce di continuo “grave, serio, intenso”, talora “irrisolvibile”. “Percorso” non ha quasi più nulla a che fare con viaggi, strade o cammini: si è esaurito in mille accezioni. “Progetto” è chiamato in causa di continuo. “In pratica”, anche nella versione “praticamente”, infioretta e sorregge ogni ciarla. Ci aspettano all’incrocio, pronti a saltarci addosso perché così fan tutti (e dove vogliamo mettere l’“eccellenza”? Ovviamente da valorizzare?).
La “discesa in campo” riguarda un innamorato deluso (che, se proprio vuol differenziarsi, “si rimette sul mercato”), un politico, un genitore, arrabbiato con i professori del figlio, che magari va a protestare dal preside (“Lei mi ha costretto a scendere in campo!”). “ Coniugare” e “declinare” hanno di soppiatto abbandonato le grammatiche per insinuarsi nella cucina (“Una torta nella quale vengono declinati molti sapori”), nella psicologia, nell’arte, nelle cure di bellezza, nel galateo. Mantengono le loro quotazioni “Sistema-Paese” e l’onnipotente verbo “fare”, che ha ingoiato vagonate di verbi più specifici e indicati al contesto. “Veicolare” ha quasi perso il significato di far circolare, trasportare, e ormai ha scavalcato “trasmettere”. “Liquido” ha cessato di indicare uno stato fisico, ma in Bauman ha un gran senso, in molti altri casi no.
La biologia fa una bella concorrenza all’economia. Si sfruttano “ metabolizzare” , “Ce l’ho nel DNA”, “È genetico” (magari la pigrizia, o la preferenza per un certo attore). Lo stesso per “assolutamente sì o no”, “sicuramente sì o no”: come mai “sì” e “no”, nella loro incisiva brevità, non sono più sufficienti e, da soli, paiono non avere compiutezza, anzi sollevare perfino dei dubbi?
Tutti ripetiamo le parole nelle loro ultimissime varianti, sotto varianti o degenerazioni, per stanchezza, emulazione: il “cento”, come si dice, è sempre più basso. Ci si attaccano come sanguisughe, le diffondiamo.
È pur vero che, forse per una sorta di nemesi, si sgonfiano anche i vocaboli più recenti, popolari e gloriosi. L’“attimino” era qui, pulsante e vitale, fino a poco tempo fa, ma era così fuggente che non c’è quasi più; “cioè” e “nella misura in cui” ci riportano ai tempi in cui Berta filava; “autoreferenziale”, dopo una fastidiosa invasione, si sta lentamente ritirando; lo “zoccolo duro” tanto duro non era, giacché sta venendo meno, è andato in pace.
Pure nella lingua scritta, generalmente più conservativa perché più stabili sono i suoi modelli, tanti piccoli assassinii sono avvenuti sotto i nostri occhi, per incuria e superficialità (vogliamo mettere sotto accusa le maestre troppo buone?). L’accento sulla prima persona di “dare”, “do”, è scomparso da anni; sta scomparendo anche su “dà”. In compenso, parecchi, a cominciare dai miei alunni, scrivono “fu” (verbo) con l’accento, forse per intensificarne la portata remota. E che dire delle maiuscole? Va bene che Manzoni, nel suo (breve) periodo di ribellione, scriveva “Papa” e “Re” con la minuscola, ma spesso adesso si scrivono con la minuscola i nomi propri e quelli geografici, e, quanto al punto, sembra non avere più alcun influsso sull’iniziale del termine successivo. Il punto e virgola, si sa, è in disuso, perché interpretato come una sosta esageratamente lunga nelle brevissime frasi dell’espressione scritta attuale. La virgola è posta a caso, quando pare bello più alla vista che all’ udito o al senso; e, dopo il soggetto e subito prima del verbo di riferimento, pur trattandosi di un classico dell’obbrobrio, sta ancora abbastanza bene, grazie, anzi, è tutto ok.
Vogliamo affrontare lo scottante tema delle virgolette? Prelevate a forza dalle pagine scritte e trasformate in un gesto – indice e medio di entrambe le mani che si abbassano contemporaneamente mentre nel frattempo il viso ammicca, nel caso non si fosse capito – sono usate quasi sempre a sproposito. Ho sentito dire “tra virgolette”, oppure le ho viste mimare, per l’appunto, anche nel caso di frasi del tipo “Oggi ho molta fame”, oppure “Ho comprato una borsa alle svendite”. E perché mai?
Per tacere del declino di egli, la sepoltura di ella, la vittoria pressoché definitiva di lui e lei, l’annichilimento totale (neppure le ceneri sopravvivono) di esso e essa, travolti, tutti, dalla forza inarrestabile dell’uso, che li ha sotterrati anche nella forma scritta.
Condividere lo stesso orizzonte linguistico impone l’accettazione di regole, per lo più anonime, che escludono il caos, difendono la peculiarità. Emerge con chiarezza che le smagliature e le falle del sistema di controllo, scuola, stampa, comunicazione, decoro, perfino, sono sempre più numerose. (E che cos’è questo smagliature, che mi è uscito di penna senza l’autorizzazione del mio io consapevole?).
Ma contro chi e che cosa si vuole combattere, in difesa dell’italiano? Si può controllare il linguaggio? Probabilmente no, così come non si possono controllare i cervelli. Eppure mantenere un certo contegno, una certa dignità nel parlare non è dissimile dal pettinarci o truccarci prima di uscire, cercando di apparire più gradevoli agli occhi altrui. Occorre cercare di parlare bene esattamente come occorre evitare di essere invadenti, prepotenti e chiassosi, e l’assecondare un uso linguistico banale o improprio dovrebbe apparire come l’assenza di un doveroso “mi scusi” pestando un piede in metropolitana. La lotta per il mantenimento della purezza di una lingua, o di un suo accettabile registro, è una lotta di civiltà, non la faccenda di esaltati parrucconi.
Dovremmo reagire come se ci attaccassero la mamma, la cucina o il Colosseo. Abituiamoci a togliere la maiuscola, toglieremo anche la punteggiatura e andremo a capo a caso (del resto, ahimè, già spesso lo si fa). Usando il congiuntivo come se fosse un preziosismo, elimineremo anche il futuro indicativo, assai spesso sostituito dal presente accompagnato da una connotazione temporale (domani pranzo fuori….lunedì vado…tra un mese sono in vacanza). Capita di domandarsi, è ancora italiano, questo? Occorrono maestri e professori più severi, più matite rosse e matite blu. Esami di italiano in ogni facoltà, umanistiche e scientifiche. Proprio perché tutti dicono “assolutamente sì”, dobbiamo imporci di non farlo. Non dirlo anche se la lingua ci prude, perché, si sa, l’uomo è un animale imitativo. Sarebbe il caso di introdurre una parola nuova alla settimana nel nostro dizionario, di esercitarci a escogitare un sinonimo per un vocabolo d’uso quotidiano. Se i nostri interlocutori non ci comprenderanno, i curiosi ce ne domanderanno spiegazioni, oppure, una volta a casa, andranno a controllare su un libro o Wikipedia; quanto ai rimanenti, lo dimenticheranno, ma questo non va a loro onore.
Dobbiamo perseguire la sensazione di pienezza che offre il padroneggiare un lingua bella ed espressiva come la nostra. Esercitare noi stessi, appartenere a quella congrega, palese o segreta, che fieramente tenta di onorare l’incommensurabile eredità ricevuta. E leggere, far leggere, parlare di letture, scrivere, tenere un diario, riassumere per iscritto ogni testo letto, come tante tacche sulla pistola.
La soppressione di ogni regola non è auspicabile, né realistica. Provvedersi di argini non significa arrestare la fiumana, ma almeno renderla più regolare. Non basterà? E chi siamo noi per dirlo? È una bella impresa, ma ne vale la pena. Perché altri non lo faranno mai al nostro posto. Assolutamente, no…”