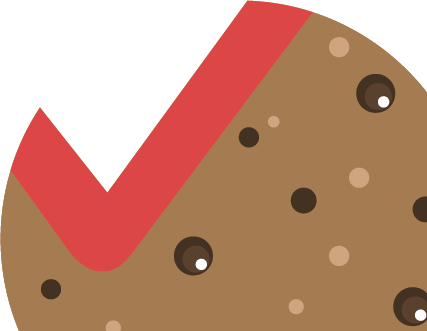(11/05/2015) Vi proponiamo un’intervista allo scrittore di origini algerine Amara Lakhous pubblicata dal quotidiano online La Voce di New York. Nell’intervista, realizzata da Teresa Fiore, lo scrittore ha parlato della lingua che ama e che usa per scrivere e del suo processo di “parziale” italianizzazione e dell’importanza di conoscere più lingue.
Amara Lakhous: la lingua italiana è la mia madre adottiva
di Teresa Fiore – La voce di New York
Nei libri del pluri-premiato scrittore Amara Lakhous, da Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio a Divorzio all’islamica e Contesa per un maialino italianissimo a San Salvario, la lingua italiana, nella sua grande varietà interna tra dialetti e prestiti stranieri, non è solo veicolo della storia, ma protagonista e metafora di tanti meccanismi culturali. Abbiamo chiesto a Lakhous di parlarcene in profondità per avere, da un italiano di origini algerine come lui, una prospettiva dinamica sul ruolo dell’italiano in quest’era globale delle lingue franche. Questa intervista con Lakhous, che da circa sei mesi vive a New York, è volta a proporre delle nuove idee per incentivare lo studio dell’italiano, attraverso l’esperienza di uno scrittore che dell’italiano ha fatto la sua patria, secondo una sua famosa espressione.
Raccontaci del tuo incontro con l’italiano dalla prospettiva di un berbero che parla l’arabo e il francese. In una recente intervista girata a Montclair State University hai detto che, mentre le lingue dell’infanzia te le sei trovate pronte, l’italiano invece te lo sei sudato.
Vengo da una tradizionale famiglia berbera di Algeri, il che è stata una doppia fortuna: da un lato, la vita in città mi ha aperto ad altre lingue come l’arabo, che ho imparato giocando per strada, mentre dall’altro mia madre, che non usciva mai di casa, ha mantenuto vivo il mio berbero. Il francese è arrivato con la scuola ed era utile per parlare con i cugini emigrati in Francia che tornavano ad Algeri in estate. Sin da piccolo ho capito che la lingua è uno strumento di potere. Grazie al mio multilinguismo facevo da interprete e mediavo tra le figure della famiglia: ero considerato speciale, trattato come figlio unico… anche se avevo cinque sorelle e tre fratelli. E poi è arrivato il primo contatto con l’italiano, attraverso un corso per principianti all’Istituto Italiano di Cultura di Algeri che ha avviato la mia scoperta, in traduzione francese, della letteratura (Calvino, Sciascia, Moravia) e soprattutto del cinema italiano (dai classici del Neorealismo alla commedia all’italiana e Fellini). Quando sono andato in Italia nel 1995, ho cominciato a studiare sistematicamente perché ero molto motivato: stavo dalla mattina alla sera a leggere alla Biblioteca Nazionale di Roma con il dizionario accanto per quando serviva – venendo dal francese il passaggio non era così difficile. Ma soprattutto ascoltavo e facevo pratica con tutti, anche se non ho preso l’accento romano…
Nel video citato prima, hai detto che una nuova lingua (per te l’italiano) è un’alleata, una forma di protezione e persino un’occasione per rinascere. Puoi spiegarci meglio queste immagini così forti e poetiche? Quanto possono essere utili a giovani che parlando una lingua franca come l’inglese, magari non intravedono il valore di questa alleata?
Io uso spesso la metafora dell’artigianato. Imparare una lingua straniera significa acquisire un attrezzo fondamentale per la vita, che alla fine è un mestiere. E anche in ottica lavorativa le lingue sono essenziali in questo mondo globalizzato. Più conosci una lingua più ti orienti, e più lingue conosci più alleati hai, e quindi vivi meglio. Adesso è il turno dell’inglese per me, ma presto vorrei imparare lo spagnolo, o forse il giapponese. Certo, per chi guarda al mondo dalla prospettiva della cultura americana significa essere in una botte di ferro e magari non si sente il bisogno di protezione, ma bisogna sempre avere una visione dinamica e guardare avanti. Gli studenti americani una volta in Italia capiranno che mentre continuano a imparare l’italiano, la loro lingua può essere un’occasione per insegnare, magari anche lavorando au pair. Vivere tra più di una lingua è un modo per uscire della gabbia che la propria lingua e la propria cultura possono creare se ci si resta comodamente dentro.
Come hai studiato l’italiano nel tempo e come lo studi ancora oggi? Tutte le lingue richiedono tanto studio, ma c’è qualche sfida particolare che intravedi nell’italiano?
Quando non sei di madre lingua e parli più lingue, devi rimanere in contatto attivo: sei vulnerabile in questo senso, puoi fare errori. Ma la vulnerabilità è una possibilità, nel senso che ti porta a relativizzare te stesso – gli errori ti ricordano l’imperfezione che fa parte del sapere più lingue, ma anche la possibilità della correzione, che è un’occasione di migliorare – non ha senso sentirsi giudicati. Imparare una lingua è un atto di umiltà che richiede senso di avventura e determinazione, come quando si impara a guidare o a nuotare, specie da adulti. E richiede una consapevolezza del percorso svolto: sapere che si sa dà forza, perché ci fa diventare dei modelli. Detto questo, si dovrebbe sempre imparare una lingua come un gioco, come se fossimo dei bambini. È un piacere, oltre a essere un impegno. Per me è stato così con l’italiano: è una lingua che ho amato e che mi ha amato. Una lingua con cui ho raggiunto un livello di intimità profonda e con cui mi sento a mio agio. Le sfide? Certo, dopotutto sono italiano, non italianissimo.
Durante il tuo intervento a Montclair State University, con una bella espressione, hai evidenziato il fatto che il tuo italiano è una lingua di carne e non una lingua di carta. Vuoi spiegarci cosa intendi esattamente con questo riferimento alla carne, e come in effetti si sposa anche con la carta? Dopotutto sei un avido lettore di letteratura italiana…
La lingua di carne è quella della gente, quella che ascolti per le strade, nei mercati. Ed è una lingua degna di rispetto. È la lingua che spesso imparano gli immigrati, per esempio. Per questo sono contro il test di italiano standard per la cittadinanza: gli immigrati parlano la lingua di carne che funziona nella loro vita italiana, ma non passano il test e perdono un’occasione importante, anche se fanno parte della società italiana. La lingua di carta è quella della scrittura, altrettanto importante. Per me gli scrittori siciliani hanno avuto un ruolo fondamentale (Sciascia, ma anche Brancati e il mio amico Consolo). Anche la Sicilia ha avuto un posto speciale nella mia esperienza italiana: nella fase iniziale in Italia quando come rifugiato non potevo tornare in Algeria, in Mazara del Vallo ho riconosciuto un luogo familiare, fatto di nord Africa, ma anche di Italia, di cui sono diventato cittadino nel 2008.
In varie occasioni ti sei espresso in maniera critica nei confronti dell’attuale legge sulla cittadinanza che esclude i figli degli immigrati in Italia, persino quelli nati in Italia, e invece apre le porte ai discendenti degli emigrati italiani nel mondo che possono anche non avere nessun legame attivo con la lingua e la cultura italiana. Come si può sostenere questa importante campagna per la riforma della legge, senza il rischio di creare forme di essenzialismo (identità = lingua)?
So che posso essere visto come conservatore a proposito di questa questione, ma per me la lingua è uno strumento fondamentale per fare parte di una società. Questo vale per gli immigrati in Italia e per i discendenti degli emigrati che vogliono acquisire la cittadinanza. Non si può essere italiani senza sentirsi italiani, e non ci si sente italiani senza la lingua.
Se fossi prescelto per essere il testimonial di una campagna a favore dello studio dell’italiano, quale sarebbe il tuo slogan, per i giovani ma anche per i meno giovani?
Una delle lingue più belle, innanzitutto per la musicalità, e poi perché e sinonimo di arte, cultura e genialità. Esprime la creatività e la fantasia italiana.
Nei tuoi libri ci sono innumerevoli riferimenti alla lingua italiana. Ci puoi proporre una scelta delle immagini più incisive?
Nel romanzo Scontro di civiltà, la metafora più forte è quella legata ad Amedeo che chiama il dizionario Zingarelli il suo biberon e la lingua italiana il suo cibo quotidiano. In Contesa uso quest’analogia tra gli esseri umani e gli alberi, che privati delle loro radici, muoiono entrambi; e concludo dicendo che non c’è radice più forte della lingua, anche se in quel caso parlo del dialetto. Ma forse è questa la metafora che veramente coglie il mio rapporto con l’italiano: io considero la lingua italiana come una madre adottiva: non mi ha messo al mondo, ma sono suo figlio…
*Teresa Fiore: Inserra Chair in Italian and Italian American Studies, Montclair State University.
Il link all’articolo sul sito della Voce di New York