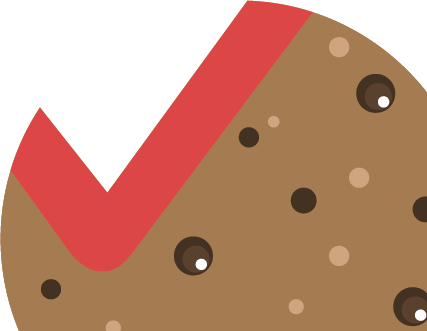(27/06/2016) In questo articolo pubblicato su wired.it le opinioni di Cecilia Robustelli e Francesco Sabatini sull’uso di alcuni termini che al momento appaiono come delle vere e proprie “novità” linguistiche provocate dall’attualità politica.
Con l’aiuto di due linguisti rispondiamo ai dubbi e alle obiezioni più frequenti sull’uso dei nomi femminili di professioni e cariche, come le nuove sindache di Roma e Torino
La questione è tornata recentemente d’attualità in seguito ai risultati elettorali di Roma e Torino. In italiano molti hanno remore nel declinare al femminile i nomi che indicano mestieri, professioni, ruoli istituzionali, soprattutto quando la posizione che rappresentano è vista come particolarmente prestigiosa. Senza restare ancorati al “sindaca sì, sindaca no”, l’argomento del sessismo nella lingua italiana merita un approfondimento, se non altro per rispondere alle tante obiezioni e alle vivaci polemiche che il discorso scatena non appena un episodio d’attualità contribuisce a riportarlo in auge. La maniera migliore è procedere per punti, prendendo spunto dalle più comuni domande e obiezioni.
1. La lingua italiana è sessista?
Non è l’italiano in sé a essere sessista, ma è senz’altro possibile adoperare una lingua in modo sessista, mettendo ai margini uno dei generi, limitandone l’utilizzo in ottemperanza a un’abitudine consolidata e avvertendolo come meno prestigioso dell’altro.
“L’uso sessista dell’italiano non è naturale, ma deriva da un retaggio culturale”, sottolinea Cecilia Robustelli, docente di Linguistica italiana all’università di Modena e Reggio Emilia e collaboratrice dell’Accademia della Crusca, da tempo attiva nel dibattito sull’uso non sessista dell’italiano.
2. Usare in modo non sessista la lingua italiana significa violentarla e mancare di rispetto alla sua tradizione linguistica e letteraria?
Per rispondere a questa domanda basta considerare il fatto che la stessa Accademia della Crusca, che ha come scopo precipuo la salvaguardia della lingua italiana, auspica l’uso di forme come “sindaca”, “prefetta”, “ingegnera” e, in generale, consiglia di prestare attenzione a un uso non discriminatorio della lingua. Come sottolinea Francesco Sabatini, linguista, lessicografo e presidente onorario dell’Accademia della Crusca, “perché la lingua cambi devono prima di tutto cambiare le cose. Ogni imposizione linguistica che non segue i cambiamenti della società è destinata a scomparire. Quando, però, come in questo caso, il cambiamento sociale è avvenuto, anche la lingua ha il dovere di adeguarsi registrandolo.” “Le parole – continua il linguista – vanno, infatti, viste non come entità astratte, ma come un rimando a persone, cose, realtà. Adoperare i nomi femminili di cariche e professioni consente alla lingua di rimandare alle persone in modo più chiaro e grammaticalmente corretto, seguendo l’impostazione dell’italiano che ha tra le proprie caratteristiche quella di presentare la distinzione in due generi, il maschile e il femminile”.
D’altra parte, le forme femminili suggerite non solo seguono perfettamente le regole di formazione delle parole della lingua italiana, ma hanno sovente radici antichissime. Ricordate l’“Orsù, dunque, avvocata nostra” della Salve Regina che tanti hanno imparato al catechismo, che traduce letteralmente il latino “Eia ergo, advocata nostra”? Chissà perché l’avvocata dovrebbe star bene nel rosario e non nelle aule dei tribunali.
Fuor di scherzo, tutte le forme femminili – di antico e nuovo utilizzo – suggerite dai linguisti che si sono occupati dell’argomento (in questo documento ne potrete trovare diverse) sono frutto di riflessione sull’etimologia della parola e non attuano alcuna forzatura sulla lingua. Non è per questo che suonano brutte, ma, come si è ampiamente sottolineato, solo perché non ci siamo abituati. In molti casi il femminile deriva dalla forma aggettivale, che usiamo tutti i giorni senza che ci sembri sgraziata.
3. I femminili delle cariche hanno significato ironico?
A molti parlanti anche colti il nome femminile di una carica o di una professione appare ironico, sminuente. Ma vi sono motivazioni razionali alla base della perplessità che queste parole suscitano? “Assolutamente no, – afferma Robustelli – non vi sono ragioni fonetiche o linguistiche che possano giustificare questa sensazione, che è senz’altro legata a motivi culturali”. Di fronte a una forma nuova o poco usata l’impreparazione può far cogliere sfumature ironiche grammaticalmente inesistenti.
“È il nuovo passo che dapprincipio ci spaventa”, aggiunge Sabatini. “Cambiamenti analoghi nella lingua avvenuti in passato oggi non ci sorprendono più perché l’uso li ha resi normali. Nessuno oggi si stupisce per la parola ragioniera, perché la conquista di questa professione da parte delle donne è già consolidata. Ma se ragioniera e infermiera vanno bene, non c’è ragione per rifiutare ingegnera”.
Come per tutto ciò che riguarda la lingua, è bene, però, non forzare la mano. Sarà il tempo ad aver ragione delle iniziali resistenze. “Personalmente consiglio di accettare piccoli margini di oscillazione nell’uso – soggiunge Sabatini – perché il nuovo ha sempre bisogno di tempo per affermarsi. Sicuramente ciò che oggi ci fa tanto discutere tra poche decine di anni sarà considerato scontato.”
4. Che cosa dire delle forme in –essa? Perché sindaca è da preferirsi a sindachessa, ma dottoressa va bene? Non è una contraddizione in termini?
I femminili in –essa meritano un discorso particolare. Il suffisso, di origine greca, era inizialmente adoperato per ricavare un femminile da un nome maschile, soprattutto con termini indicanti relazioni familiari (per esempio “principessa” da “principe”). A partire dalla fine dell’Ottocento, in effetti, talvolta, alcune forme in –essa furono adoperate, in letteratura e nella stampa, con intento ironico e denigratorio verso le donne, creando forme ridicolmente pompose, come ricorda Migliorini nella sua Storia della lingua italiana: “queste deputatesse pettorute”, “le nostre snobesse anglomani”. Di qui l’idea che il suffisso –essa abbia una sfumatura derisoria.
“Alma Sabatini, autrice nel 1987 del primo studio sul sessismo nella lingua italiana, propose di sostituire quasi tutte le forme in –essa”, sottolinea Robustelli. “Ma chiaramente non ha senso farlo per parole entrate nell’uso e prive di connotazioni ironiche o dispregiative come dottoressa, professoressa, poetessa”, aggiunge la linguista, sottolineando come sia sempre meglio preservare forme radicate nell’uso, perché ogni forzatura in un organismo vivo e vitale come la lingua è fuori luogo.
5. Ma si parla di non forzare la lingua e poi si cerca di imporre l’uso dei femminili delle cariche. Non è una contraddizione?
Nient’affatto, perché l’uso delle forme femminili è già parte integrante della lingua italiana. “Le norme che riguardano il genere grammaticale sono insite nel sistema della lingua e non sono una forzatura. Noi usiamo quotidianamente termini di genere femminile, e non maschile, in riferimento alle donne: maestra, parrucchiera, ragioniera…”, afferma Robustelli. “La vera forzatura, semmai, è trattare la lingua come se fosse un’entità immobile, che prescinde dai cambiamenti della società”, aggiunge la linguista.
D’altra parte, come sottolinea Sabatini, “continuare a escludere dall’uso le forme femminili è di fatto discriminatorio, perché questa scelta non si fonda su ragioni linguistiche, ma nasconde un pregiudizio. È come affermare, indirettamente, che determinati ruoli rimangono una prerogativa maschile”.
6. Accettare forme come sindaca e ingegnera è un’assurdità: per analogia bisognerebbe accettare forme come registo, piloto, farmacisto, no? E perché va bene architetta mentre giudice rimane così?
Tra tutte le obiezioni questa è quella che fa più sospirare i linguisti, perché nasconde una scarsa consapevolezza delle origini delle parole che usiamo ogni giorno, oltre che poca dimestichezza con le regole grammaticali. L’associazione del genere maschile con la desinenza –o è talmente automatica nella mente di qualcuno da mettere in ombra il fatto che anche l’italiano conosce diversi maschili in –a (i cui suffissi rimandano generalmente a un’origine greca).
La stragrande maggioranza di questi nomi resta invariata nel femminile, rientrando nei cosiddetti nomi di genere comune, in cui la differenza tra maschile e femminile è data solo dall’eventuale presenza dell’articolo o di un aggettivo: “il regista/la regista”, “il pilota/la pilota”, “il farmacista/la farmacista” e così via. Tra i nomi di genere comune rientrano anche molte forme in –e, come “il giudice/la giudice”. Nessuna contraddizione, quindi, e nessuna necessità di coniare nuove forme al di fuori della tradizione linguistica e grammaticale.
7. L’uso di sindaco anche per le donne non può essere motivato dal fatto che si tratta del nome della carica, con valore neutro e forma invariabile? Da questo punto di vista “signora sindaco” andrebbe benissimo.
Qui ci troviamo di fronte a due errori: in primo luogo la lingua italiana, pur derivando da quella latina, che aveva effettivamente tre generi (maschile, femminile e neutro), presenta un sistema morfosintattico semplificato a due generi: maschile e femminile.
Il maschile può avere talvolta valore inclusivo, ma non si parla di neutro. “Quanto al presunto nome invariabile della carica – aggiunge Robustelli – mi sembra che qui ci si trovi di fronte a un classico errore di confusione tra semantica e morfologia, cioè tra significato della parola ed elementi grammaticali”.
Nella parola sindaco, così come in sindaca, è la radice “sindac–” a rimandare al significato, ovvero alla carica istituzionale. La –a e la –o servono solo a indicare se la carica è ricoperta da un uomo o da una donna. Ma siccome storicamente questa carica è stata appannaggio degli uomini, istintivamente il maschile ci appare come più rappresentativo del ruolo. Ma, per fortuna, le cose stanno cambiando e la lingua, come è naturale, dovrà seguire questo cambiamento.
8. Sarebbe, quindi, opportuno intervenire anche sulle concordanze? Frasi come “Marco, Lucia e Anna sono simpatici” dovrebbero essere cambiate scrivendo “simpatiche”, accordandosi con il genere più numeroso o più vicino?
“Sarebbe un’inutile forzatura”, afferma Robustelli. “Dobbiamo sempre ricordarci di avere a che fare con una lunga tradizione linguistica-letteraria che non è possibile ignorare e che prescrive in questi casi l’uso del maschile, che assume valore inclusivo del femminile. Vedremo, tuttavia, se questa regola cambierà: ma certo non possiamo né vogliamo cambiarla noi a tavolino”.
La nostra lingua è tradizionalmente androcentrica (centrata sul genere maschile) e assegna, quindi, questa funzione inclusiva solo al maschile. In questo caso sarà l’uso, in maniera del tutto spontanea, a sancire un eventuale cambiamento nella norma tradizionale. Non è possibile intervenire sulla morfosintassi in modo forzato.
9. Ma con tutti i problemi sociali e politici che ci sono in Italia (o nella città di turno), perché fissarsi su una questione così insignificante come il femminile delle cariche? Alle stesse donne non converrebbe fare battaglie per ben altri diritti?
Non c’è dibattito sulla politica, sulla società o sulla cultura che, in Italia, non termini con il richiamo ai ben altri problemi che dovrebbero avere la precedenza. Poche questioni sembrano essere immuni dal benaltrismo nazionale. Vi sono senz’altro problemi più stringenti delle questioni linguistiche, ma svilire il ruolo della lingua non rende giustizia alla sua importanza sociale e culturale, al suo profondo valore simbolico.